
Nella simbologia di Pasolini è la rosa ad avere un posto di primo piano.
Plurimi i significati simbolici. Ci si potrebbe riferire a Iside dell’antico Egitto o ad Afrodite del pantheon greco e romano, divinità alle quali il fiore era consacrato. Ineludibile principalmente il legame con il mito della Gran Madre quale fertile espressione della “Femminilità Generatrice” che potrebbe esplicare il senso del titolo dato alla silloge Poesia in forma di rosa, pubblicata nel maggio 1964, dove nel componimento Una disperata vitalità si legge:
La morte non è / nel non poter comunicare / ma nel non poter più essere compresi.
Un soggetto antitetico all’archetipo della Grande madre della natura, dell’energia arcaica e dell’istinto si trova nel componimento Ballata delle madri che apre la raccolta nella sezione intitolata “Realtà”.
Il poeta, utilizzando metafore distruttive, ha toni sferzanti che manifestano rabbia e rancore.
L’atto d’accusa è rivolto a quelle madri che, avendo offerto ai propri figli pensieri privi d’amore, hanno contribuito a produrre i guasti della società consumistica e borghese come, per esempio, il conformismo e l’ubbidiente sottomissione.
La rappresentazione, oltre a essere sferzante, è provocatoria. Sono chiamate “vili”, “mediocri”, “servili”, “feroci” le madri che educano all’adattamento a una società malata.
La ballata delle madri di Pasolini: analisi e commento
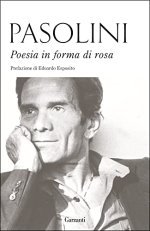
Link affiliato
Entrando nella profondità del componimento appare evidente che l’essere madre non potrà mai sradicare l’amore e nemmeno potrà subordinare al dominio.
La prospettiva pedagogico- educativa alla quale Pasolini si richiama si mantiene così distante dalla schiavizzazione dei figli che dovranno diventare futuri guerrieri con l’esercizio del libero pensiero.
L’incipit si caratterizza come monologo e, nel contempo, dialogo. Il poeta si interroga e interroga gli interlocutori asserviti al potere (i giornalisti, specificamente), facendo risaltare il loro cedimento ai compromessi:
Mi domando che madri avete avuto.
Se ora vi vedessero al lavoro
in un mondo a loro sconosciuto,
presi in un giro mai compiuto
da esperienze così diverse dalle loro,
che sguardo avrebbero negli occhi?
Se fossero lì, mentre voi scrivete
il vostro pezzo, conformisti e barocchi,
o lo passate a redattori rotti
a ogni compromesso, capirebbero chi siete?
Il riferimento è ai figli di una borghesia senza scrupoli i quali sono il bersaglio del poeta; dopo prendono corpo i versi in cui le <>, lontane dalla dimensione spirituale, sono soggiogate dal sistema patriarcale:
Madri vili, con nel viso il timore
antico, quello che come un male
deforma i lineamenti in un biancore
che li annebbia, li allontana dal cuore,
li chiude nel vecchio rifiuto morale.
Madri vili, poverine, preoccupate
che i figli conoscano la viltà
per chiedere un posto, per essere pratici,
per non offendere anime privilegiate,
per difendersi da ogni pietà.
“Poverine” le chiama anche a mo’ di comprensione per essere l’espressione oggettuale di una società autoritaria dove l’organizzazione le esclude e le allontana dalla realtà socio-lavorativa.
Pur trattandosi di “anti-madri” che non appartengono più alla genealogia della Gran Madre, si immedesima il poeta nella loro condizione servile, le cui umiliazioni subite hanno modificato i loro “lineamenti” e “comportamenti”.
Da qui l’adattamento ad una società ammalata, a una vita senza slanci: mediocre perché il solo intento dei figli è quello di inginocchiarsi al più forte per un posto di lavoro.
L’opposizione è dunque radicale, rivolta al sistema borghese il cui interesse materiale ha separato le madri da una sacra femminilità: quella delle ragioni del cuore (la tenerezza, la passione, l’empatia).
L’assenza le fa precipitare nel girone della vile mediocrità. Sicché, la loro identità si esprime in modo anaffettivo senza alcuna relazione col dolore e con la gioia:
Madri mediocri, che hanno imparato
con umiltà di bambine, di noi,
un unico, nudo significato,
con anime in cui il mondo è dannato
a non dare né dolore né gioia.
Madri mediocri, che non hanno avuto
per voi mai una parola d’amore,
se non da un amore sordidamente muto
di bestia, e in esso v’hanno cresciuto,
impotenti ai reali richiami del cuore.
La relazione madre-figli che si svolge entro lo scenario patriarcale del dominio è fortemente disturbata al punto che già nella vita intrauterina le creature ricevono le stimmate della viltà: è il “servo”, in sostanza, a discendere dalle “madri servili” con la conseguenza di non disporre d’una mente critica e di tradire la sua appartenenza alla stessa classe sociale di provenienza:
Madri servili, abituate da secoli
a chinare senza amore la testa,
a trasmettere al loro feto l’antico,
vergognoso segreto d’accontentarsi dei resti della festa.
Madri servili, che vi hanno insegnato
come il servo può essere felice
odiando chi è, come lui, legato
come può essere, tradendo, beato,
e sicuro, facendo ciò che non dice.
L’escalation di Pasolini giunge a dirle “madri feroci” malgrado ritenga che non siano direttamente colpevoli: anch’esse vittime senza via di fuga; anch’esse offese e umiliate da un sistema insensato e competitivo che le assedia:
Madri feroci, intente a difendere
quel poco che, borghesi, possiedono,
la normalità e lo stipendio,
quasi con rabbia di chi si vendichi
o sia stretto da un assurdo assedio.
Madri feroci, che vi hanno detto:
Sopravvivete! Pensate a voi!
Non provate mai pietà o rispetto
per nessuno, covate nel petto
la vostra integrità di avvoltoi.
Lo schema antropologico è chiaro: il poeta procede dal primigenio culto della “Gran Madre” e giunge al dominio esercitato dal patriarcato generatore della condizione borghese connotata dall’egoismo e dalla legge del più forte.
Tutti, madri e figli, sono lo strumento inconsapevole di un mondo i cui disvalori sono visti nell’omologazione e nel rifiuto della diversità intesa come minaccia dell’ordine costituito.
Da qui il ritorno al “selvaggio dolore di esser uomini” che si legge nell’ultimo verso del componimento, in cui può scorgersi l’integrazione junghiana del maschile col femminile, nonché l’indipendenza dei ragazzi da un modello materno possessivamente vorace.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: “La ballata delle madri” di Pasolini: una poesia-critica al patriarcato
Naviga per parole chiave
Approfondimenti su libri... e non solo Poesia News Libri Pier Paolo Pasolini Storia della letteratura
Lascia il tuo commento