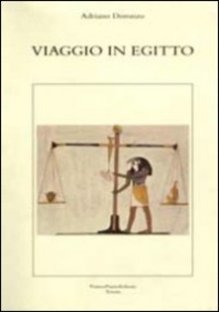
Viaggio in Egitto
- Autore: Adriano Doronzo
- Categoria: Poesia
- Anno di pubblicazione: 2003
Nella mitologia greca, la fonte Castalia possiede il potere di elargire facoltà poetiche e creative a coloro che ne bevono le acque terse e leggere. Essa discende dalle pendici del Monte Parnaso ed è consacrata alle Muse. La sua origine è legata a una ninfa che, per sfuggire alle attenzioni amorose del dio Apollo, si gettò in questa sorgente. Secondo altre versioni del mito, fu il dio stesso, offeso dal rifiuto dall’amadriade Castalia, a trasformarla nella fonte che da lei prese il nome. Castalia è il nome di una Collana editoriale della FrancoPuzzo Editore: se seguiamo la catena di risonanze profonde che lega, all’interno del mito, le qualità prodigiose di una fonte sacra, la simbologia fortemente chiaroscurata legata all’elemento acqua, l’ispirazione poetica e il dominio solare di Apollo, possediamo già una prima rudimentale mappa per percorrere la silloge poetica di Adriano Doronzo Viaggio in Egitto (FrancoPuzzoEditore, 2003, pp. 30).
Diario mistico e spirituale di un’anima alla ricerca della lampada della verità, la raccolta si inanella, con grazia allusiva e misteriosa, intorno a due poli magnetici che aggregano, nello sforzo di incarnare i contrasti drammatici dell’esistenza e dell’uomo alla ricerca di senso, le opposte immagini della tenebra e della luce, del dolore e dell’estasi, della morte e della vita, del caos e dell’armonia, della perdizione e del ritrovamento del Sé profondo, sepolto sotto le macerie di un Io bramoso di infinito e di eternità.
Le soavi acque della fonte Castalia, in questo sottile gioco di metafore e di simboli, ora brillano nella loro delicata e solare lucentezza incarnando estasi e mistici trasalimenti, ora si inabissano nelle acque di Averno il cui corso fangoso e greve esprime la pesantezza della materia e il giogo della mortalità umana. Il Nilo, che bagna i versi del poeta, raccoglie metaforicamente in sé entrambe le acque, come la terra in cui scorre e che è al contempo luogo di illuminazione e di smarrimento, di ascesi e di sprofondamento nella prigione terrestre che serra l’anima in una morsa angosciosa. Il raffinato e sapienziale contrappunto numerologico nella scansione delle composizioni e delle pagine crea un sottofondo di rimandi e di rivelazioni esoteriche che richiama al lettore esperto di viaggi dell’anima i celebri versi di Dante:
“O voi ch’avete li ‘ntelletti sani / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ‘l velame de li versi strani”. (Inferno, canto IX, vv. 61-63)
“Ti vengo a leggere, vita / Delle tue vene il senso, / […] Per il Nilo che spezza in due il grande corpo / Accarezzandone l’anima”.
Sin dai primi versi che aprono la silloge il poeta – pellegrino nel paese della schiavitù e del peccato secondo la tradizione ebraico-cristiana, ma anche della sapienza arcana e della rivelazione iniziatica secondo la tradizione esoterica della philosophia perrenis – dichiara il proprio intento e definisce l’orizzonte della sua ricerca. Si viaggia per trovare il senso e la pienezza della vita, a tratti guidati dal sole che rischiara e dà forza, a tratti dalla luna che confonde e inganna.
In uno splendido mattutino iniziatico e alchemico, il poeta accoglie le opposte influenze del giorno e della notte, nello sforzo di trovare quella coniunctio oppositorum che da sempre travaglia ed eccita l’umano spirito.
“Due pesci neri neri / Nell’acqua verdognola ingiallita dal sole / E due uccellini magri magri / Sopra i gradini ombreggiati dal verde papiro”.
Il nero della nigredo, in cui il piombo dei nostri corpi ancora invischiati nel fango dell’inconsapevolezza attende la sua trasmutazione in oro, si condensa da una parte nel simbolo dei pesci, esploratori silenti degli abissi ignoti, e dall’altra nell’immagine degli uccelli neri e scheletrici, metafora dell’opacità della materia e della morte, ma anche della sua alata facoltà di ascendere e liberarsi nelle uraniche pianure. I semi di luce, presagio dell’oro filosofale, sono già presenti nella notte: è il giallo del sole che si riflette nelle acque e il verde dei papiri, colore che ci rammenta la viriditas, il verdeggiare della vita, simbolo dello spirito potenziato e decantato nella sua quintessenza divina. Ed ecco che, accompagnata da questi presagi, si annuncia l’albedo alchemica, primo segno della trasformazione interiore:
“Fresca, l’alba giunge silenziosa, sulle acque calde, / Pare un attimo fa, che camminavo nel buio / E sono secoli che la mia essenza ristagna / Nelle terrene paludi”.
L’uomo cammina tra cielo e terra, tra paradiso e inferno, e se è veramente fedele a se stesso non si acquieta mai nella sua condizione mortale e fragile: un grido di eternità squarcia incessantemente i silenzi della sua anima. Sa di essere fragile, fallibile e disperso, ma sa anche, con la stessa inamovibile chiaroveggenza, di essere forte, stabile e imperituro, dotato di quella scintilla di infinito che attende solo di essere alimentata in fuoco e fiamma celeste, fino al vertice di una coscienza di diamante, specchio di verità e perfezione.
“Come posso guardare laggiù oltre quelle montagne / Quando a stento vedo i miei più stupidi e banali peccati?”
L’uomo in ricerca conosce se stesso, sa i vincoli e le catene che impacciano il volo cosmico in vista del quale è stato creato dal nulla. Pesa, a volte, il corpo, quello stesso corpo che è anche sintesi suprema di armonia e principio di vita glorificata, qualora il raggio dello spirito lo vivifichi e lo nutra.
“E prima che notte s’avvicini sarò già mattino luccicante! / Guardo una Rosa, resistere al vento”.
Il passo successivo alla coscienza del proprio limite è il sopravvenire di una condizione trasfigurata che il poeta, con un’immagine potentemente lirica e iniziatica, evoca attraverso l’identità tra anima e “mattino”. Egli è il “mattino”, il suo essere più profondo “è” quella luce che tutto rischiara, quel raggio che si riverbera sulla “Rosa” che sa opporsi alle bordate del vento sempre mutevole e ingannevole del tempo e degli umori umani. La Rosa è il simbolo per eccellenza della perfezione di tutte le più alte facoltà umane e divine: bellezza, totalità, pienezza, eternità gemmante dell’essere, grazia che sboccia senza fine, amore e gratuità celeste.
Non esiste notte che non possa essere vinta dall’aurora che, a ogni nuovo mattino, versa la sua risanante e fresca rugiada su tutte le cose raggelate e tramortite dal soffio terribile del buio:
“E un anello luminoso salì lento al cielo, / E quando il canto vibrò nelle stanze delle antiche regine / Un calore infinito mi avvolse”.
Le “stanze” sono i luoghi dell’anima che, come accade nel castello mistico di Santa Teresa d’Avila, si succedono secondo una gradazione qualitativa, da quelle più esterne, caotiche, affollate e rumorose, a quelle più interne e protette, pulite, consacrate al silenzio e al colloquio con il divino.
“Ritornai deciso alla fresca parete / Dopo che quelle precise parole / Mi placarono la sete”.
La freschezza è un altro attributo della condizione liberata e aperta, come lo erano il verdeggiare e l’aprirsi della Rosa asilo di beatitudine. Ciò finalmente placa l’arsura del nostro andare senza sosta, perché alla fine di ogni errare vi è sempre quell’acqua castalia che estingue i mortali desideri dell’uomo inquieto.
La sapienza è l’approdo di questo viaggio tra cielo e terra, conquista impervia che esige una disciplina e una consapevolezza delicate come cristallo e incorruttibili come il diamante:
“Portavo un serpente al guinzaglio / E lui usciti di casa, stranamente mi minacciò, / Ritornai presto al chiuso / E sotto il tetto compresi / Dove il serpente doveva stare, / E quanta strada avevo ancora da fare”.
Il serpente, simbolo della sapienza ma anche delle forze demoniche che si agitano nel profondo, non si lascia addomesticare né dominare con facilità. Spesso non siamo noi a cercare, afferrare e conquistare la sapienza, ma è lei a cercarci, a prenderci e a invaderci quando giunge il momento destinato e noi siamo pronti. Il nostro compito è prepararle una dimora adatta per accoglierla e ospitarla, una dimora che la persuade a rimanere con noi e in noi.
Come nella dantesca selva oscura, il viaggiatore vive le sue notti dell’anima:
“Nelle valli adombrate dall’inaccessibile segreto / Ho a lungo vegliato”.
Questa veglia è sacra, preludio al momento in cui “l’anello che non tiene” viene rinforzato in nuova forgia e nuova indistruttibile materia:
“L’anello congiunse le parti staccate / E il gran soffio cullò / Delle sfere addormentate, / Il canto, / Un unico suono nell’infinito, / La materia creò l’amore”.
Solo lo spirito raccoglie le pagine sparse della creazione nel grande Libro della Vita, nell’armonia suprema del Cosmo, riparando quell’anello che una modernità scettica e inaridita ha fiaccato e spezzato, con il triste esito di scompaginare il Libro in un caos senza senso di lettere e parole non più connesse. E l’amore, motore della creazione, è anche il rilegatore celeste di questo Libro, colui che fin dalle origini ha raccolto le pagine, le ha cucite insieme secondo ordine e armonia, le ha rivestite di una copertina d’oro e gemme perché l’uomo ne fosse attratto e persuaso ad aprirlo per leggervi dentro i propri alti destini.
E l’amore, che si affaccia nei primi versi di Doronzo come principio di ogni cosa, è anche il sigillo del viaggio, l’apice di questa odissea nella terra dei faraoni figli del Cielo e delle divinità dai capelli azzurri e dalle membra turgide e splendenti come le pietre preziose, la terra dove quello stesso Sole che illumina il cammino e infonde coraggio conosce anche l’orrore della notte, allorché scende sulla sua barca nelle case dei morti governate da Osiride e combatte con Apofi, divinità della tenebra e del caos, correndo il rischio di essere sconfitto e divorato. Così è la vita, finché la guardiamo entro i ristretti confini della mortalità: un Sole che brevemente splende e che in ogni attimo rischia di venir assalito dalle potenze delle tenebre e della morte. Ma chi segue la via della sapienza conosce un altro Sole, stabile, eterno e buono, ricco di amore e di grazia, la cui luce ammansisce anche Apofi e dissipa ogni nebbia e torpore:
“L’antica saggezza / Reca sempre con sé / un lieve soffio di amore, / Spero che la bocca / Del mio cuore / Abbia abbastanza forza / Per donarti questo soffio / Finché avrò vita”.
La conoscenza è salvezza, ci suggerisce il poeta, e il suo respiro d’amore ci rende – noi creature sempre erranti e fragili, impastate di terra e di sole, di fango e di cielo – capaci a nostra volta di amare.
L’Egitto di Doronzo diventa così lo scrigno dove è custodita la perla che, nel celebre Canto gnostico a essa dedicato (Canto della perla), l’anima deve cercare e trovare per ottenere la sua veste di luce e di immortalità. La tessitura poetica rarefatta, sospesa e silenziosa, lascia spazio solo all’essenziale, in un lavoro di spogliazione da ogni orpello e retorica, alla ricerca di una misura aurea e di un equilibrio tra detto e non-detto, tra velamento e rivelazione. Il velo di Iside non viene mai lacerato da una parola troppo forte o da un impeto troppo acceso, ma appena mosso, sfiorato, accarezzato, con parole sussurrate nella fresca penombra del tempio interiore. E la dea sapiente, grata per tanta delicatezza e umiltà, a sua volta risponde, ma anch’essa sussurrando, piano piano, per oracoli, segni e segreti.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Viaggio in Egitto







Lascia il tuo commento