
La raccolta di Pier Paolo Pasolini Poesia in forma di rosa, edita da Garzanti nel maggio 1964, si presenta in forma autobiografica, psicologica e ideologico-politica con tratti di rabbia nei confronti di una società disgregata e amorfa.
È composta da componimenti che vanno da ‘61 al ‘63, distribuiti in diverse sezioni, di cui la quinta, intitolata “Una disperata vitalità”, si apre con il componimento Poema per un verso di Shakespeare.
Il verso del drammaturgo inglese William Shakespeare, citato nel corso dell’opera, è quello che nell’Otello raccoglie le ultime parole di Jago:
“Ciò che hai saputo hai saputo, il resto non lo saprai”.
Essendo la tematica abbastanza complessa e articolata, ci soffermiamo appena su qualche aspetto, puntando l’attenzione sui primi versi, densi di riferimenti simbolici.
“Poema per un verso di Shakespeare” di Pasolini: testo e analisi
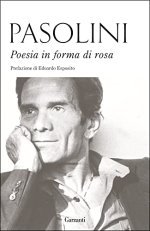
Link affiliato
È la luna alle dieci del mattino che sparisce dal cielo e abbandona il poeta per migrare come un uccello nei mesi di pioggia.
Tornerà la notte seguente e intanto egli si gode il risveglio della vita, annunciato dai colpi di scure dello spaccalegna:
Nell’angolo buio delle dieci del mattino, mi lascia
e se ne sta come un uccello nei mesi di pioggia -
emigrato da terre che non hanno ancora un nome -
che si nasconde in qualche boscaglia a dormire quando
il giorno incomincia [...]
Eh, uccellaccio dormiente! grigio come il fango,
bianco come il sole delle dieci del mattino, col capo in-
nocentemente senza vita sotto l’ala,
io non so dove, non so come – ma so che ci sei. Anzi,
direi che, nel tuo silenzio mattutino, nella tua assenza, la
voglia di morire è ancora più chiara:
e infatti è come un bambino che io mi godo quest’ora
concessa ancora una volta, le dieci, con la pioggia, i ru-
mori del quartiere tenacemente intonati
sui colpi di scure uno spaccalegna in qualche
giardino in mezzo alla città.
Riprendendo l’accostamento della luna con l’uccello, chiama poi l’astro notturno:
uccellaccia nera, che ti fingi bianca, / come una sposa di paese, / con ali di rapace / nei teneri grigiori del Friuli / uccellaccia con l’occhio maligno, che si finge chiuso / nel beato sonno di chi sa paesaggi di foreste e deserti / mai visti…
L’aquila nera con cui l’uccellaccia è identificata è segno lunare e femminile e da rapace si avventa sul poeta/capretto, trascinandolo su.
Il simbolismo della luna si arricchisce ulteriormente, chiamandola il poeta “sacco di pannocchie di luce”. L’allusione va alla Dea dell’agricoltura e della fecondità Cerere. “Candida e cattiva”, soffia la sua anima sul prato, individuato da Zigania come il luogo del sacrificio del poeta.
Ci si trova dunque dinanzi a una complessità di simboli sulla luna che infine viene chiamata “uccelletto” in questi accattivanti versi:
Lei si è ritirata a dormire: ricordo
che così dormono gli uccelletti che cacciano
i ragazzetti friulani, nei dopopranzi
in cui il Tagliamento è grande come un deserto,
e, tra le viti ferme come in sogno e i gelsi
che già profumano di seta, i campi di pannocchie
sono come branchi di leoni ruggenti.
Essi dormono, o covano sonno,
in qualche albero che è un sogno trovare […]
A far urlare di rabbia il poeta è il conservatorismo della Chiesa, la cui colpa è d’aver dimenticato la carità.
Al fine di enfatizzare lo sdegno, Pasolini utilizza le maiuscole:
SE LA CHIESA DI DIO È UNA CASA CHIUSA DAL DI DENTRO
E LUI SOLO HA LE CHIAVI, ANCH’IO
SONO VISSUTO IN UNA CASA CHIUSA DALL’INTERNO
LA CASA DELLA RAGIONE SORELLA DELLA PIETÀ.
Ho aperto
la porta, e ne sono uscito...
“La casa della ragione”: vale a dire la solarità patriarcale cui si deve la prigionia del poeta insieme agli esseri umani, allontanandolo così dalla pietà, cioè dalla Gran Madre. In sintesi, Pasolini in questo componimento racconta per flussi di coscienza e associazioni di idee un lungo viaggio attraverso “le strade nazionali della cattività” (il boom economico, la fine del neorealismo, l’avvento della Nuova Preistoria, le borgate dei ragazzi amati):
Finito un ciclo di rapporti ideali, una storia, / è così che sempre si difende un’anima: / facendo gloria della propria sconfitta.
Il tragitto si conclude ad Assisi con un grido per la morte dell’uomo usato come merce e Giotto, profondamente da Pasolini amato, è dentro quella morte (in Porcile è indicato a fondamento della società borghese responsabile della fine della Storia.
Ma nel Decameron pasoliniano, è noto, Giotto torna ad essere amato: il celebre pittore del Trecento sarà proprio lui).
Grido nell’aria di chiesa:
Amo anche la morte di Giotto,
che non mi piace più, laggiù, in quella triste navata,
piccola come una navicella pirata,
pittore con la testa corta come l’Umbria!
Potrei anche dare una mano di calce
su quei memorabili affreschi pieni di devoti
che fanno i devoti, col santo marroncino, slavato
che contro colate di blu di prussia,
fa il santo: Dissociazione senza più Allusione,
CHE LA MORTE DEI VIVI VUOLE LA MORTE DEI MORTI.
Detta espressione, enunciata a mo’ di massima, per la studiosa Anna Marzio significa: “il vuoto spirituale dei vivi [...] rende incapaci di immaginare la rigenerazione dei morti, la ciclicità insita nella natura”.
Sicché, il grido è contro i restauratori:
...tradisco i lividi / moralisti che hanno fatto del socialismo un cattolicesimo / ugualmente noioso.
Nella conclusione Pasolini afferma: “ABIURO DAL RIDICOLO DECENNIO”, rinnegando totalmente il passato degli anni Cinquanta per i suoi fallimenti.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: “Poema per un verso di Shakespeare”: allegoria e profezia nella poesia di Pasolini
Naviga per parole chiave
Approfondimenti su libri... e non solo Poesia News Libri Pier Paolo Pasolini Storia della letteratura
Lascia il tuo commento